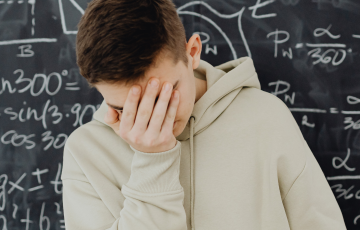ENGIM Veneto partecipa al 12 Convegno internazionale del Centro Studi Erickson per parlare di Buona scuola e di nuovi linguaggi per una cultura inclusiva. Un'occasione di confronto sui grandi cambiamenti che caratterizzano scuola e società tenutosi a Rimini lo scorso 15,16 e 17 Novembre 2019
L’intervento della dott.ssa Rigo si concentra sull’urgenza delle società occidentali a forte rischio di crisi sociale di far fronte alla complessità economica sociale ed ambientale, con azioni che promuovono l'attenzione alla biodiversità, allo sviluppo sostenibile, al pluralismo, all’intercultura, alla solidarietà, alla cooperazione educativa, alla ‘co-costruzione di storie, eventi e contesti’.
In questo scenario prende una rilevanza particolare l'attenzione agli aspetti legati alla comunicazione e diffusione della cultura, che richiede necessariamente l'utilizzo di linguaggi e modalità contemporanei e attenti ai segni dei tempi (era 5.0).
Una cultura inclusiva necessita della capacità di riconoscere le barriere presenti nei contesti, che vanno ben oltre quelle architettoniche, e si nascondono nel linguaggio, nelle abitudini, nei pregiudizi sociali, nelle scelte politiche; necessita della capacità di inventare nuovi supporti e facilitatori alla partecipazione sociale.
Promuovere quindi una cultura inclusiva implica operare in ogni contesto sociale al fine di ridurre gli ostacoli creati da ciò che si fa e si dice, comprese le azioni attuate a livello di comunicazione.
Il workshop ha avuto lo scopo di esplorare i nuovi linguaggi per l’inclusione analizzando i diversi linguaggi: visivo, verbale, culturale.
La dott.ssa Marta Rigo ha analizzato alcune campagne video di promozione della cultura dell'inclusione nazionali ed internazionali e le diverse modalità di comunicazione scelte.
Sono stati presentati progetti nati con l'intento di diffondere e promuovere la cultura dell'inclusione attraverso l'uso di linguaggi contemporanei nel contesto italiano e approfonditi i "people first language" come linguaggio che promuove la cultura dell’inclusione.
I modelli concettuali più accreditati oggi in materia di inclusione e nello specifico sulla disabilità, la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità dell’Onu, sottoscritta anche dall’Italia, invitano a dare attenzione e valore alle persone, agli esseri umani, in primis, aggiungendo, se necessario, l’attributo che si desidera considerare e che caratterizza solo parte della loro vita ( persona con disabilità, persona con sindrome di Down, … ).
Il linguaggio inclusivo aderisce alle nuove visioni a proposito delle disabilità, delle vulnerabilità, delle condizioni di difficoltà, e nel suo complesso delle diversità, aiutandoci a superare modalità obsolete e veicolanti purtroppo immagini stigmatizzanti e distorte, in grado di rasentare a volte l’offesa.
L’analisi di alcuni articoli e blog nazionali hanno evidenziato come “i toni della narrazione prevalenti nei blog sono volti ad attirare l’attenzione dei lettori attraverso quelli che possono essere considerati ‘incidenti critici’ delle persone con vulnerabilità, eventi eccezionali, o che non appartengono alla vita quotidiana, quasi a sottolineare l’aspetto ‘spettacolare e straordinario’, ‘fuori dall’ordinario’ della disabilità e dell’inclusione" *
Questa ricerca sottolinea la necessità ancora forte di promuovere strategie comunicative per l'inclusione. la cultura dell’inclusione passa dall’uso delle parole più corrette. Ci si è infine interrogati su quali siano i termini da promuovere per una maggior cultura dell’inclusione:
- Unicità: a noi piacerebbe che venisse utilizzata molto più frequentemente, e spesso al posto di espressioni come ‘diverso’, ‘eccezionale’, ‘speciale’, in quanto rappresenta la massima sottolineatura dell’importanza, del rispetto e dell’insostituibilità di ogni singola persona in quanto, appunto, unica, originale e irripetibile.
Essere e considerarsi unici significa affermare che ha poco senso parlare di diversità, pensare a come ‘misurare’ e classificare le persone, come farle rientrare in questa o quella categoria. Se salta la possibilità del confronto, la necessità di individuare di volta in volta i diversi o i più diversi, salta anche l’idea dell’esistenza di persone da inserire, da integrare, da ospitare, da accogliere e si farà probabilmente più strada l’idea di contesti e ambienti comuni per tutti e, pertanto, strutturalmente inclusivi e votati alla personalizzazione del modo di concepire e trattare ogni persona. - Reciprocità: Teniamo molto al costrutto della reciprocità in quanto, in sua assenza, i rapporti si strutturano in termini di potere, di dominanza, di sottomissione, ostacolando di fatto la comparsa di quell’interdipendenza che costituisce il focus stesso dell’inclusione.
- Complessità: essa innanzitutto ci invita a resistere alla tentazione di ancorarci a visioni semplicistiche e riduttive soprattutto quando siamo chiamati a confrontarci con tematiche che comportano la ricerca di spiegazioni e soluzioni che hanno a che fare con il benessere presente e futuro delle persone. Condivisione che oltre a suggerire la necessità di mettere in comune i nostri saperi, i nostri linguaggi e le nostre metodologie di analisi e di progettazione della realtà ci fa sorgere il desiderio che sia possibile mettere in comune anche dell’altro, proponendo l’idea della compartecipazione, la sharing economy, il mettere in comune.
Unicità, reciprocità, complessità, condivisione: sono parole che rinviano certamente a costrutti impegnativi come, d’altra parte, è impegnativa l’inclusione senza se e senza ma.